Maggio 2023: due alluvioni a distanza di quindici giorni devastano le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Tra settembre e ottobre 2024 altri due nubifragi colpiscono la zona di Bologna e i Comuni limitrofi, creando nuovi danni a Faenza e nel ravennate. L’Emilia-Romagna continua a pagare le conseguenze del disastro: diciotto persone hanno perso la vita, oltre 40mila sono rimaste temporaneamente sfollate. Ma c’è anche chi non è più riuscito a tornare a casa. Chi ha perso speranza e fiducia nelle istituzioni, perché alle proprie domande non ha mai trovato risposta. Qualcuno ha scelto di condividere con noi la propria esperienza, raccontando come è cambiata la loro vita dopo l’alluvione: gli strascichi economici, morali, talvolta anche fisici di questa vicenda. Una sequenza di episodi intensi e ravvicinati che raccontano di un clima che sta cambiando ad alta velocità. Siamo arrivati al 2025: mentre gli esperti mettono in allerta sul futuro, la tecnologia cerca di procedere spedita alla ricerca di soluzioni per la ricostruzione.
Alluvioni a confronto – Il maltempo di maggio 2023 ha fatto cadere in Emilia-Romagna circa 450mm di acqua. Il quantitativo che occorrerebbe per riempire 66 piscine domestiche. Il centro storico di Faenza è finito sott’acqua e altri Comuni come Lugo, Bagnacavallo, Conselice e Sant’Agata sul Santerno sono stati devastati per la rottura degli argini dei fiumi. A settembre 2024 i livelli di piovosità hanno superato ogni record, con picchi di 350mm di pioggia in 24 ore. Frane e allagamenti hanno toccato i territori già danneggiati e l’area metropolitana bolognese. Nel mese di ottobre 2024 le precipitazioni sono state inferiori, ma hanno creato danni pesanti a Bologna e nei suoi Comuni limitrofi, come San Lazzaro di Savena e Pianoro.

Il parere della comunità scientifica – Daniele Cat Berro, analista climatico di Società Meteorologica Italiana, evidenzia le caratteristiche delle precipitazioni: “Le piogge del 2023 sono state più concentrate, nel 2024 invece sono state più violente. Tutti gli eventi alluvionali hanno mostrato caratteri straordinari, ancor più se considerati in sequenza”. Secondo l’esperto, quello che preoccupa è l’alta frequenza degli eventi alluvionali: “È ormai accertata un’alternanza di intense precipitazioni e siccità che in gergo è detta “colpo di frusta”. Ci troviamo di fronte a un clima nuovo che impone un’impresa colossale di gestione degli eventi atmosferici”.
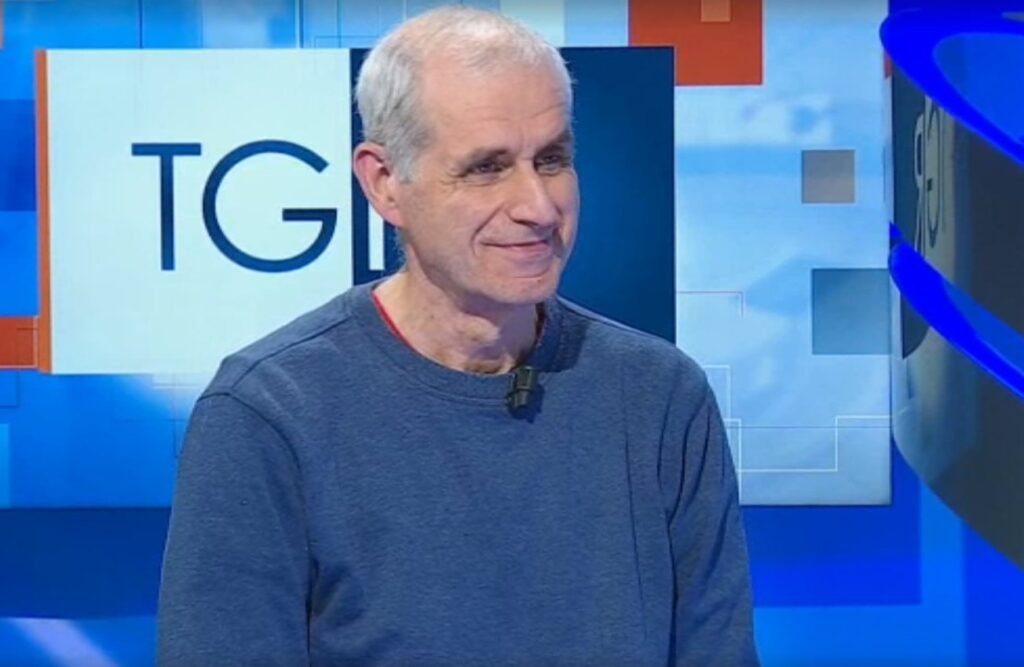
Le sfide del clima – Negli ultimi anni, i fenomeni di pioggia intensa sono diventati sempre più frequenti. “L’alluvione del 17 maggio 2023, con la rottura simultanea degli argini di 24 corsi d’acqua, ha evidenziato quanto il rischio sia stato sottovalutato – sostiene il climatologo Pierluigi Randi, presidente dell’Associazione Meteorologi Professionisti Ampro – Il riscaldamento globale sta intensificando gli eventi estremi e le recenti alluvioni difficilmente resteranno episodi isolati. Il territorio dell’Emilia-Romagna non è pronto ad affrontare il clima del futuro: i fiumi, ormai ridotti a stretti torrenti, non riescono più a contenere precipitazioni così intense”. Secondo l’esperto occorre effettuare al più presto un ampliamento degli alvei, ma è necessario un approccio più avanzato: “Sfruttando dati, tecnologia e intelligenza artificiale potremmo migliorare la gestione del rischio. È necessario agire con una strategia di adattamento del clima a lungo termine”.
Un pericolo già noto – Quello della manutenzione degli alvei dei fiumi è un problema conosciuto da tempo. Una questione ben evidenziata nel documento di valutazione “Piano di gestione del rischio di alluvioni” elaborato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2013. Secondo le analisi di quell’anno, le situazioni più critiche riguardavano alcuni tratti dei fiumi Lamone, Montone e Savio, tre corsi d’acqua che hanno rotto gli argini più volte tra il 2023 e il 2024. Il documento stabiliva anche una mappatura del territorio regionale in base alla probabilità di evento alluvionale: il parametro del “Tempo di ritorno per evento critico”. L’analisi segnalava una “pericolosità elevata” per il centro abitato di Sant’Agata sul Santerno, piccolo Comune della Provincia di Ravenna che è stato allagato quasi completamente a maggio 2023. Il fiume ha rotto gli argini di fronte alla casa di Alessandra Pizzuto, che oggi si sente abbandonata: “Non so cosa dire ai miei figli, questo non verrà mai ripagato abbastanza”. Nel disastro ha perso 3 auto e tutto il piano terra della propria abitazione. Le sue parole diventano lacrime quando ricorda dell’aiuto ricevuto da decine di volontari, gli “angeli del fango”: “Almeno abbiamo capito che a qualcuno importava qualcosa di noi”.
Un modello per tutti – L’acqua raggiunge ogni anfratto con una potenza distruttiva. Così il territorio della Val di Zena, sull’Appennino bolognese, nell’alluvione di ottobre 2024 è stato inghiottito da una corrente che ha lasciato fango, detriti e devastazione. La casa di Elisa Buriani, a Botteghino di Zocca, frazione di Pianoro, è rimasta inagibile. La raggiungiamo mentre sta rientrando dalla famiglia nell’appartamento in affitto che dista 40 minuti dal luogo di lavoro: “Io ho scelto di vivere in Val di Zena, ho ristrutturato e installato le barriere anti-alluvione. Perché non posso rientrare?”. La risposta resta ovattata, come un grido che resta imprigionato sotto la superficie dell’acqua. Per rispondere alle sfide del cambiamento climatico con un approccio scientifico, la facoltà di Ingegneria Idraulica dell’Università di Modena e Reggio Emilia ha inaugurato, pochi giorni fa, un nuovo studio idrologico in Val di Zena, la cui finalità è quella di individuare le criticità della zona attraverso l’uso di droni e riprese satellitari.
“Il piano punta a mettere in sicurezza il territorio tenendo conto della sua portata idraulica in risposta ad intense precipitazioni. Per farlo ci avvaliamo dell’intelligenza artificiale, utilizziamo algoritmi e tecnologie di ultima generazione” spiega il prof. Stefano Orlandini, uno dei referenti accademici del progetto. Il modello è esportabile anche al di fuori della Val di Zena e non solo in Emilia-Romagna, perché un costante monitoraggio della pulizia del letto dei fiumi è essenziale ovunque per ridurre il rischio di esondazioni.
La risposta nel coordinamento – I cambiamenti climatici alimentano dubbi e paure nella mente dei cittadini. “Abbiamo sbagliato a cantare “Romagna mia”, a mostrarci così forti. Qui i paesi si sono sviluppati attorno ai fiumi. Adesso cosa facciamo? Buttiamo giù tutto?”. Tiziana Naldoni, di Castel Bolognese, descrive così il proprio sconforto davanti a una realtà che, come turbolenza, disorienta il suo viaggio nei ricordi. La scomparsa di un vicino di casa e la perdita della sua tappezzeria, poi riaperta dal figlio Marco, lasciano però spazio alla fiducia nei giovani, che nell’alluvione hanno trovato un motivo di rivalsa: “Avevano i piedi che sanguinavano e hanno coordinato i moltissimi volontari che sono arrivati. Molti di loro, oggi, fanno parte della protezione civile locale”. Proprio per ottimizzare il funzionamento della macchina dei soccorsi nelle emergenze, la Città metropolitana di Bologna ha colto la palla al balzo e punta ora a creare un centro di coordinamento di protezione civile che possa avere un ruolo di riferimento per i Comuni.
Uniti nell’emergenza – Conselice fa parte dei territori maggiormente colpiti dall’alluvione del 17 maggio 2023. Roberto Alberti racconta con orgoglio la storia del gruppo volontari “Lombardina”, che proprio lì ha istituito un centro logistico per la distribuzione di beni di prima necessità durante l’emergenza: “È successo tutto senza che ce ne accorgessimo. Ci siamo arrangiati con quello che avevamo: ricetrasmittenti, zattere e piccoli generatori. Poi, attraverso il passaparola dei volontari, anche organizzazioni come Greenpeace ed Emergency si sono rivolte a noi per fornire viveri e attrezzature. Stiamo continuando a dare una mano anche oggi e lo facciamo volentieri”.
Rassegnazione – Il post alluvione è anche un insieme di volti delusi, lo spettro di una rassegnazione che colpisce molti cittadini. Elena Cavallucci abita a Faenza e, prima del disastro, aveva coronato il proprio sogno: gestire una ludoteca, con un parco giochi per bambini e una fattoria. “Qui ho investito tutto e adesso non vale più niente. Chi la comprerebbe?” esclama con delusione. Un metro e mezzo d’acqua ha messo in pericolo il suo progetto di vita, ma è niente in confronto alle conseguenze psicologiche lasciate dall’alluvione: “È difficile vivere così, ogni volta che piove ho il cuore in gola”. La sua storia non è molto diversa da quella di Daniela Montano, residente di Via Ex Tiro a Segno, a Cesena, una delle prime strade ad essere inondate a maggio 2023. L’acqua ha impregnato i muri del primo piano della sua abitazione, rendendolo inutilizzabile. Ma è come se, allo stesso tempo, fosse penetrata nel suo stato d’animo, tanto da comprometterlo per sempre: “È come dover elaborare un lutto, la vita cambia completamente. Io ho commesso un grande errore: mi sono fidata e affidata alle istituzioni. Le promesse non sono state mantenute, ora mi fido solo di me stessa”. Nelle sue parole c’è la paura di continuare a vivere in un territorio che percepisce come insicuro.

Il punto sulla ricostruzione – Un’insicurezza che i comitati Borgo Alluvionato, Fluire e Forese Faentino hanno espresso in una lettera aperta al commissario per la ricostruzione post alluvione, Fabrizio Curcio, segnalando il notevole ritardo nella programmazione di interventi manutentivi per il contenimento dell’acqua. Per non parlare della piattaforma Sfinge, che i cittadini dovrebbero utilizzare per chiedere i ristori per i danni da alluvione. Secondo i comitati, solo il 3% degli aventi diritto ha depositato la propria domanda, dopo una procedura che impone perizie, certificazioni e dichiarazioni di conformità. Dopo tutto, i cittadini emiliano-romagnoli hanno davvero bisogno di questo?







